GIORNO PER GIORNO 11 marzo
- Andrea Colombu

- 11 mar 2021
- Tempo di lettura: 3 min
11 marzo 1966
Barcellona Caputxinada: dopo tre giorni d’assedio la polizia irrompe nella sede dei cappuccini per interrompere il primo coordinamento clandestino degli studenti che si battevano contro il regime franchista


Da più di sei mesi, in assoluta clandestinità, gli studenti universitari della città catalana si incontravano e discutevano, facoltà per facoltà, sfidando la repressione dell’occhiuto regime franchista.
Si trattava di formare un organismo che si opponesse al finto sindacato universitario controllato dal regime. Discussioni e discussioni tra piccoli gruppi poi nominare i delegati per un’assemblea generale e stabilire alcuni punti per una mobilitazione collettiva. Come prevedibile, nonostante l’uso di ogni cautela, la cosa era diventata nota alla polizia politica franchista, a conoscenza del fatto, ma non del luogo scelto. L’appuntamento era stato fissato per il 9 marzo nella Sala d’atti del Convento dei Cappuccini di Sarrià (ordine religioso che, a differenza di altri, aveva deciso di accogliere l’opposizione al regime). Si presentarono più di 450 delegati delle facoltà universitarie col coordinamento di Jordi Rubi y Balaguer, direttore della prestigiosa Biblioteca de Catalunya. L’assemblea era già iniziata quando con un cospicuo dispiegamento di forze armate, comandate dal commissario Juan Creix, il Convento venne circondato e posto sotto assedio per tre giorni, assedio passato alla storia come la Caputxinada.

Dopo la vittoria nel 1939 del generale Francisco Franco, appoggiato dai bombardieri dell’Italia di Mussolini e della Germania di Hitler, sulla legittima Repubblica, per due decenni era proseguita una resistenza armata nella zona di confine con la Francia, in Galizia, nelle Asturias, in Catalogna e Aragona. Generoso tentativo, doloroso, pagato con il sacrificio di migliaia di vite, con la prigione e l’esilio. Dopo il 1960 con l’omicidio di uno dei più famosi e amati uomini della resistenza, l’anarchico Francisco Sabaté Llopart detto "El Quico”, una pesantissima cappa di oppressione avvolge la Spagna, mentre il suo regime fascista veniva dimenticato e ogni suo atto repressivo contro l’opposizione clandestina cadeva sotto silenzio e ignorato in Europa e nel resto del mondo.

Il 9 marzo del 1966 Il commissario Vicente Juan Creix e il commissario del governo, Camilo Alonso Vega fecero circondare il monastero e ordinarono ai presenti di lasciare l'edificio. Poche persone lo fecero e vennero fermate, identificate e poi denunciate. Il resto dei presenti che non potevano comunicare con l’esterno in alcun modo continuarono le discussioni, decisi a stare rinchiusi fino a che non venisse garantito loro di non subire rappresaglie. Tale decisione poté farsi forte dell’appoggio del Padre provinciale dei Frati Minori, Joan Botam i Casals, e dei suoi confratelli, che iniziarono a distribuire coperte e panini in un luogo non preparato ad accogliere tante persone, che tuttavia vennero considerati ospiti e da tali trattati per parte dei Cappuccini.
L’11 marzo la polizia, incurante del moto di solidarietà che aveva suscitato la mobilitazione studentesca, fa irruzione in forze nell’edificio, che pur godeva, per un trattato col Vaticano, del diritto all’inviolabilità: L’arresto di tutti i ragazzi, condannati anche a pesanti multe venne accompagnata da una massiccia campagna di stampa del regime: per tre giorni, scrivevano i giornali più succubi, centinaia di ragazzi e ragazze avevano convissuto giorno e notte dividendosi spazi e coperte. Quale accusa poteva sembrare più infamante per i poliziotti e giornalisti di quel genere?

Come accade, il calcolo costi/benefici non è facile da fare e spesso rivela la stupidità di chi pensa che basti la repressione per interrompere un processo di cambiamento. L’assedio, gli arresti, l’allontanamento dei docenti che avevano solidarizzato con gli studenti suscitarono un inarrestabile moto di simpatia, provocando uno scollamento tra il regime e le classi medie da cui i ragazzi provenivano.
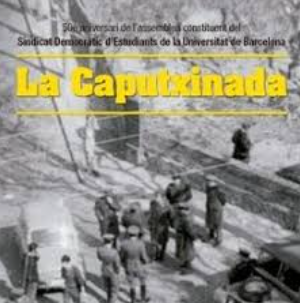
E soprattutto l’azione poliziesca innescò immediatamente un processo moltiplicatore della mobilitazione nelle università. Il sabato successivo scendono in piazza gli studenti a Barcellona e a Salamanca. Il mese successivo persino una manifestazione di protesta dei preti contro il regime. Un progressivo innalzarsi dei livelli di organizzazione e di scontro che preparano la strada alle occupazioni massicce degli anni successivi.
Del resto, cosa ci può essere di più liberatorio del lancio da una finestra di una facoltà occupata del busto di marmo di Francisco Franco? Come diranno gli studenti catalani applaudendo il gesto nel giugno del 1969.
Il documento conclusivo dell’assemblea catalana posta sotto assedio aveva affermato:
“l’Università non può rimanere isolata dai problemi, dalle aspirazioni e dalle attitudini degli uomini della nostra società. Affermiamo come dovere ineludibile dell’Università la difesa della libertà là dove sia posta in pericolo, la lotta per conseguirla là dove non c’è”
e si concludeva così:
“la nostra università deve prendere tra le sue mani la causa della libertà della cultura ed inserirla nell’ampio orizzonte della lotta per la libertà all’interno della società spagnola”.




Commenti